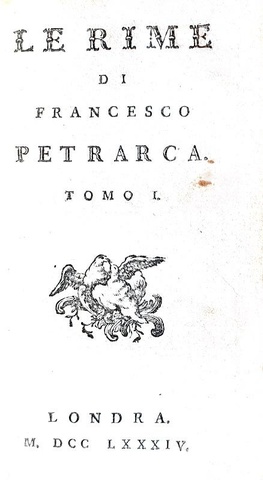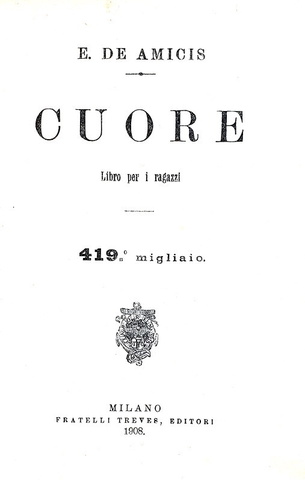Alberto Vigevani - Libri e cultura a Firenze agli inizi degli anni Quaranta

A leggerle e rileggerle, queste pagine, vien voglia di chiosarle all'infinito, percorrendo la storia di quegli anni con titoli di libri, con pagine di diario, con epistolari o carteggi tra quei grandi protagonisti di una stagione irripetibile.
Vigevani descrive, con la semplicità della cronaca, una stagione straordinaria: basta leggere uno in fila all'altro i nomi dei personaggi citati in queste pagine, e pensare a cosa hanno significato quei nomi per la letteratura e la storia del nostro Novecento, per capire l'eccezionalità del luogo e delle frequentazioni di un personaggio pure lui straordinario nel panorama nazionale.
Altri vanno pubblicando altre pagine di questo aureo libretto, ma questa, forse meno poetica ed evocativa, è eccezionalmente densa: all'appello potrebbe forse mancare il solo Papini, in quegli anni corrispondente e amico di Ridolfi, e senza dubbio frequentatore delle Giubbe Rosse: ed era già una gloria nazionale.
Stridente, per me che amo quel luogo e quei personaggi, è piuttosto l'oblio in cui alcuni di essi son caduti. Ma riproporli e rileggerli è forse il modo migliore per recuperare non solo la memoria, ma un clima culturale estremamente vivace, che è un bell'esempio per noi post-novecenteschi, forse ancora reclinati ad ossequiare quel secolo da cui veniamo e a cui fieramente riteniamo di appartenere ma dal quale troppo spesso non riusciamo a staccarci per dare al nostro tempo la nostra impronta originale, così come quegli uomini fecero col loro tempo.
Buona lettura!
Alberto Vigevani, Libri non ancora antichi.
Questi frammenti, o brani, dovrebbero concernere libri antichi, ma la memoria è vagabonda, da uno scaffale passa a un altro e so che è difficile contrastare o resistere ai suoi capricci, ai suoi, diciamolo pure, voltafaccia. Tanto più che io stesso ho scritto parecchi libri, certo più di quanti avrei dovuto, e a metà della mia esistenza sono diventato amministratore di una casa editrice e poi editore per conto mio.
Parlo adesso di Firenze. La mia vita fiorentina è divisa in due tronconi, tra libri antichi e libri nuovi (addirittura inediti o in bozze), cuciti soltanto dalla mia inestinguibile devozione per la cucina toscana casareccia (non so se ne esiste un'altra, al di fuori di quella descritta in rari manoscritti dei Medici o dei Lorena). Ancora oggi mi torna a tratti il desiderio dei tre famosi lessi di manzo di razza chianina che si gustavano al Coco lezzone, e delle zuppe dell'Antico fattore: pappa e ribollita. Marcello, che sostituiva a volte il panciuto padre nel servirle, di recente m'han detto che è andato in pensione dopo una lunga carriera di professore d'italiano alle medie. Siamo stati certamente noi, a corromperlo.
Rivedo il largo e lungo tavolo che occupavamo, noi ‘letterati'. Quando per la prima volta mi ci sedetti, provai un senso d'importanza, subito sconfitto da Montale che, al mio richiamo del cameriere, mi snobbò, dicendo con sussiego: «Qui si dice ‘tavoleggiante'». Suo ammiratore, l'osservazione e soprattutto il tono m'intimidì, come il farsesco atteggiamento che assunse Tommaso Landolfi nei miei riguardi, inchinandosi quasi a terra e chiamandomi «conte». Ma quella di mettere a disagio i nuovi venuti, doveva essere una consuetudine. Dei presenti ero amico di Carlo Emilio Gadda e di Carlo Bo, che allora veniva di rado, andando a Urbino: ci vedevamo più spesso a Milano, alle Tre Marie o la sera al Savini. Presto divenni intimo anche di Antonio Delfini e Carlo Levi. Oltre alla solita compagnia, venivano la madre di Donatella Carena, la signora Chessa, col pittore Martina, il marchese di Villanova, e un giovane (ancora più di me): Leoni, impiegato alle ferrovie e amico di Jahier.
Avevo poco più di vent'anni. A diciannove pubblicai un lungo racconto su «Letteratura» e già mi sentivo un epigono di «Solaria» (come disse molti anni dopo Silvio Guarnieri), altri racconti o articoli pubblicai su «Corrente» e «Prospettive». Mi atteggiavo, senza riuscirvi troppo, a ermetico: era la moda di quegli anni. Per alcuni una copertura del proprio antifascismo, per pochi altri una copertura del proprio vuoto: in specie per chi si occupava d'arte o di poesia. A farmi venire a Firenze era stata la straordinaria generosità di Alessandro Bonsanti, succeduto a Montale nella direzione del Gabinetto Vieusseux. Ero stato presentato a lui da Giansiro Ferrata, che allora abitava con la moglie Ginetta in via Borghetto. Ricordo l'altissima scala che portava al suo appartamento e la mia emozione nel salirla, stringendo il manoscritto del racconto poi pubblicato su «Letteratura».
Bonsanti mi incoraggiò - al punto che ritengo di dovere alla sua cara amicizia se mi persuasi a pubblicare il primo libro, dal titolo (credo dovuto a un verso della Dickinson) Erba d'infanzia. Ed ero venuto a Firenze per correggere le bozze a mano a mano che componevano il testo i fratelli Parenti, nella piccola officina oltre il Mugnone, lungo il quale passeggiavo discorrendo di letteratura con Bonsanti. Il soggetto era spesso Proust o talora James, che entrambi ammiravamo.
Mi fermai circa due mesi, per correggere prime e seconde bozze. Ogni settimana andavo a Milano a trovare mia moglie, e poi tornavo nella mia stanza all'albergo Berchielli, sul lungarno. Era frequentato da vedove o zitelle inglesi con curiosi cappellini ornati di fiori di stoffa. Una di esse attaccava discorso per tessere elogi di Mussolini, «del vostro duce», che da poco aveva inaugurato le leggi razziali. Non potevo certo deluderla, con l'aria che tirava: già dovevo firmare ciò che pubblicavo con uno pseudonimo, come Marcella, la moglie di Bonsanti, le sue traduzioni. Strinsi amicizia con Antonio Delfini, qualche sera, uscendo dai tavoli da gioco, familiari a lui e a Landolfi, di cui ammiravo, per l'atmosfera kafkiana, Il mar delle blatte, da poco pubblicato nelle edizioni degli eroici fratelli Parenti, che perdevano le loro notti senza guadagnar nulla per la nostra letteratura allora quasi senza lettori. Le storie che raccontava Delfini m'incantavano.
Apparteneva a una famiglia di ricchi proprietari terrieri e aveva ereditato decine di poderi di buona terra, credo in Emilia. Ma non aveva voglia di occuparsene e aveva cambiato tutto in lingotti d'oro, il cui numero stava progressivamente diminuendo perché Delfini perdeva parecchio al gioco, come Landolfi. Si vergognava di essere stato insignito della «sciarpa Littoria», onorificenza riservata a chi aveva compiuto la marcia su Roma. Gliel'avevano data perché era il più ricco del paese, pur non avendo potuto compierla (la marcia) perché all'epoca non aveva ancora quattordici anni. Facevamo tardi la sera. Entrambi non eravamo dei veri ermetici; quelli veri, con le dovute eccezioni, li prendevamo un po' in giro.
Il caffè letterario più famoso, l'equivalente delle nostre Tre Marie ambrosiane e del romano Greco, erano le Giubbe rosse, auspici Montale e Giuseppe De Robertis, cui facevano corona Luzi, Bigongiari, Parronchi e altri. In faccia, ma letterariamente un po' decaduto, era il Pazkowski, ancora frequentato da Raffaello Franchi e Ottone Rosai, che doveva la sua aureola di gloria al ricordo di Dino Campana che distribuiva i suoi Canti orfici, stampati economicamente da un tipografo di Marradi, strappando la dedica al kaiser (ne posseggo una copia integra). Raramente incontravo nella piazza, fra i due caffè, Vasco Pratolini, che subito scompariva nel sotterraneo, a fianco delle Giubbe, per interminabili partite a biliardo. Romano Bilenchi, che ammiravo tra i più promettenti scrittori della sua generazione, era sempre indisposto e andai a trovarlo due o tre volte a casa.
Bonsanti si mescolava poco ai letterati dei caffè, riceveva al Vieusseux. Si trovava a chiacchierare nella pasticceria in una parallela di via Tornabuoni, dal nome che suonava ridicolo: «Digerini e Marinai», dove incontrava Paolo Guicciardini, Roberto Ridolfi, Aldo Olschki, tutti più anziani di lui e, naturalmente, di me. Mi condusse con sé due o tre volte. Ridolfi lo rividi dopo la guerra, nelle mie incursioni di antiquario di libri.
Tutt'altro che ermetico era Carlo Levi, cugino di Natalia e Paola che avevo conosciuto a Torino, in casa dei miei parenti De Benedetti che nulla avevano a che vedere con gli omonimi assai facoltosi. Paola, divorziata o separata da Adriano Olivetti, abitava in quell'anno a San Domenico di Fiesole, mentre Carlo fruiva di un ampio studio luminoso in piazza Donatello. Credo fosse arrivato da poco dal confino e si era messo a dipingere con gran lena. Da quel che ricordo aveva fatto un ritratto a Montale e uno a Carlo Emilio Gadda e io andavo quasi ogni giorno nel suo studio perché voleva farne uno anche a me. Dopo le pose, leggeva un capitolo di quello che divenne un libro famoso, Cristo si è fermato a Eboli. Nella prima stesura, così diversa da quella conosciuta, il libro, che anche allora parlava della gente e dell'atmosfera tra cui Levi era confinato, sembrava soprattutto un ampio, programmatico pamphlet politico, ispirato alle idee di Giustizia e Libertà. Uscendo dallo studio di Carlo, oltre che un letterato, mi sentivo un cospiratore.
Carlo dipinse anche in quei mesi, oltre ai ritratti che ho detto, un quadro collettivo, che intitolò L'Idra, perché raffigurava le teste di Montale, Bo, Contini, Gadda, del marchese di Villanova e la mia. Mi rincresce di non sapere dove il dipinto, che ha certamente un valore documentario per quegli anni, sia finito. Ho chiesto in giro ma non ne ho trovato traccia.
Nell'ultimo periodo che stetti a Firenze era già scoppiata la guerra e mi è impossibile dimenticare la notte di luna piena in cui, invitati da Carlo e Paola a cena a San Domenico, Carlo Emilio Gadda ed io salimmo a piedi per la strada romana fino a villa Olivetti.
Era estate, faceva un gran caldo e la salita si mostrava più gravosa del previsto, in specie per il mio assai più anziano compagno che, chiedendone cerimoniosamente il permesso, si tolse la giacca del vestito grigio così scuro da parere luttuoso. Col gilè e le maniche della camicia che uscivano a sbuffo, strette da elastici neri, aveva l'aria ottocentesca di un professionista o un funzionario statale in vacanza: gli mancava soltanto la paglietta o magiostrina. Dopo cena Carlo, che aveva un po' bevuto l'ottimo Lessona delle cantine Olivetti, ci lesse qualche pagina del suo libro. Rimase con Paola. Carlo Emilio ed io scendemmo quasi all'una.
Era una notte «fastosamente dannunziana», sogghignò il mio compagno: la luna splendeva piena nel cielo, si ergevano cipressi come nere spade contro i muri di pietre bianchissime e le architetture fantomatiche delle ville. A un tratto, sulla campagna silenziosa, irruppe il lacerante ululato delle sirene. Uno dei primi allarmi aerei. Carlo Emilio, ch'era stato in guerra nel ‘15, si spaventò, mettendosi a correre per la discesa e gridandomi di andare lungo i muri delle ville. Io ridevo del suo spavento e, raggiuntolo, tentai di rassicurarlo: «Qui gl'inglesi non bombarderanno mai: molte ville sono di loro compatrioti...». Tutt'altro che convinto, mi fissò come stravolto e continuò ad andare di buon passo, bofonchiando accidenti contro gl'inglesi, il duce e fors'anche contro di me, così stolto da non intendere il pericolo. Appena arrivati alle soglie delle città, l'allarme cessò.
Aveva ragione nel rimproverarmi la mia incoscienza che veniva dal fatto ch'ero giovane e i generosi fratelli Parenti stavano componendo il mio primo libro che sarebbe uscito con un mio ritratto di Domenico Cantatore in antiporta (l'originale è andato perduto). In più, nonostante fossi sposato, mi doveva raggiungere a Firenze un altro, fresco flirt... Quegli anni, pur sotto l'incubo della guerra, i problemi che poneva la persecuzione razziale, furono forse i più felici della mia esistenza: splendono nella memoria come smaltati.
(Tratto da: Alberto Vigevani, La febbre dei libri. Memorie di un libraio bibliofilo, Palermo, Sellerio, 2000, pp. 231-237).