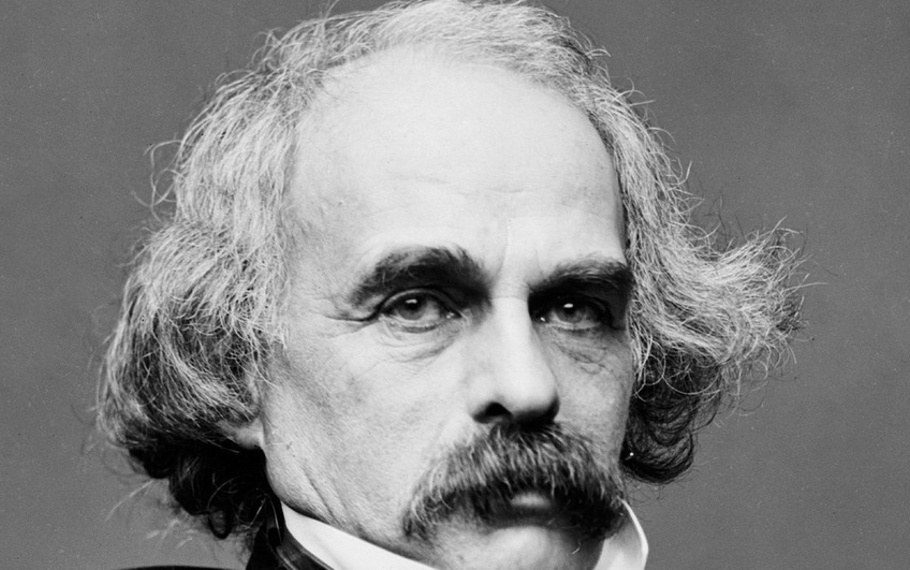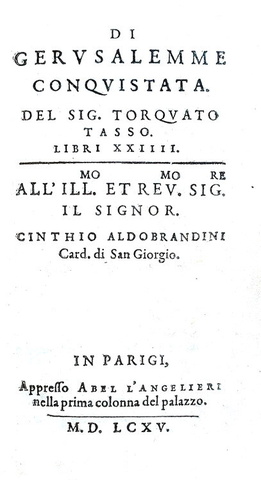Roberto Ridolfi - Gatti e gatti (Corriere della Sera, 1973)

ROBERTO RIDOLFI, Gatti e gatti, «Corriere della Sera», 9.xi.1973, p. 3.
Sognai, mi gera un gato / e ti me carezzevi. In verità non mi ricordo di aver mai sognato di essere un gatto, come canterellava Tremerello nel famoso libro del Pellico. Ma ho fatto di più: tante volte mi sono riconosciuto nei miei fratelli gatti, addirittura mi sono sentito uno di loro.
Questo m'ha sempre impedito «per la contradizion che nol consente» d'intendermela coi cani e di possederne, se non una volta un maraviglioso setter Laverack, regalatomi da una bella ragazza; il quale seminò lo scompiglio e la disperazione tra i miei fedelissimi amici (sì, fedelissimi: quella dei «gatti traditori» è una diceria sciocca e bugiarda). Donne, donne: guardate che ribalderie uno può commettere per i vostri begli occhi.
Certo, se si vuole entrar nelle grazie di quelle bestiole, c'è tutto un modo di maneggiarle e di trattarle; anche con amichevoli dispettucci, paragonabili a certe fiorentinerie tra fiorentini: i dispettucci, si sa, mantengono le amicizie. Ma tra me e i gatti c'è soprattutto una simpatia che scocca alla prima occhiata; e non soltanto con quelli del vicinato, coi quali ci si conosce almeno di vista, ma con tutti quelli che mi càpita d'incontrare. In qualunque casa o bottega io entri, o addirittura per la strada, se c'è un gatto di buoni costumi, o meglio ancora una gatta, viene difilato da me: in me, fra tanta gente che può esserci attorno, ha riconosciuto subito l'anima gemella. É una cosa che ha della stregoneria: se io credessi alla metempsicosi come i buddisti, direi di essere stato gatto prima che uomo. Se così fosse, come ognuno vede, avrei peggiorato parecchio.
Qualche ritrattino di gatto, in punta di penna, fra tutti quelli della mia vita. Ruggero fu il primo, l'amico dell'infanzia e dell'adolescenza: era di pel maculato, d'un colore ruggine che forse aveva suggerito l'idea del suo nome. La sua statura era gigantesca: tra i domestici, mai più ne ho visto uno uguale. Monsù Raffaello, il cuoco, lo raccolse ancor cucciolo durante uno dei nostri soggiorni estivi a Livorno, proprio sulla banchina del porto; e così io venivo almanaccando che un marinaio o un viaggiatore l'avesse portato seco dalle favolose terre del sud. Sulle pagine del Salgari e su quelle dei trattati di zoologia, dei quali ero allora ghiottissimo, fantasticavo che fosse il frutto di qualche mostruoso accoppiamento e avesse nelle vene il sangue di certi gattoni delle foreste tropicali, conosciuti in quei libri e vagheggiati nelle vetrine della Specola fiorentina.
Che discendesse da qualche fiera e che quella discendenza avesse parte nella sua fenomenale statura è tuttavia lecito dubitare; nessun dubbio invece può esserci sulla parte che v'ebbe il suo secondo padre, Monsù Raffaello, il quale se l'era affigliolato e lo mandava in giro con un cartello al collo, dov'era scritto: «Chi mi tocca muore»; firmato: «Ruggero Livorno». Lo tirava su a ciotole di latte di gallina, dov'erano sbattuti i tuorli di due o tre coppie d'uova, a piattini di sugo di carne cruda spremuta, a grandi fette di magro scelto. Come fu cresciuto, usava metterlo di guardia alla carne che lasciava sul tagliere, sotto la carta gialla e un canovaccio: una quantità enorme, con tutte le ganasce che allora lavoravano in casa, tra padronali e mercenarie; né c'era pericolo che scioperassero. Ruggero si acciambellava sul canovaccio, e non trovò mai un suo simile di tanto coraggio e di così poco giudizio che si arrischiasse ad avvicinarsi.
Era il terrore di tutti i gatti maschi del vicinato, ma non dei gatti soltanto. Una volta erano in visita alla Baronta certe signorinelle con un loro cane lupo. Passeggiavano nel giardino quando, sbucato da un cespuglio, Ruggero piombò con un gran salto sulla groppa del malcapitato, come avrebbe fatto un tigrotto a un bufalo, artigliandolo e azzannandogli il collo ferocemente. Inutilmente il povero lupo si rovesciò sul groppone, si rotolò, annaspò con le zampe per cercare di liberarsi. Macché! Ruggero lo aveva uncinato e azzannato a regola d'arte e lavorando di denti doveva avergli rotto una vena dei collo, dal quale grondava sangue a fontanella in modo da far pietà. La vittima guaiva, le ragazze piangevano, tempestando coi loro fragili ombrellini da sole, che difatti si ruppero, l'inferocito Ruggero; ma Ruggero non lasciava la presa. A fargliela lasciare ci volle tutta l'autorità che avevo su di lui.
Aveva un'intelligenza che direi umana, se non mi sembrasse di fargli torto. Quando s'era a tavola, donde ogni bestia a quattro gambe era rigorosamente bandita, preso il momento giusto, s'infilava sotto la mia seggiola in modo che sarebbe stato difficile scorgerlo, tra la non molta luce della stanza e l'ombra del nascondiglio, tra le massicce gambe della seggiola e quelle mie. Di soppiatto, gli passavo qualche buon bocconcino; finché, arrivati alle frutte, gli facevo vedere una buccia di pera o di mela: e lui, sgattaiolando, subito se ne andava.
In quel tempo facevo la prima colazione giù nella sala da pranzo, quasi sempre solo, essendo io fino da allora l'ultimo a scendere nonostante i rabbuffi. Mi faceva compagnia Ruggero; una compagnia del tutto disinteressata, perché del caffellatte e del pane imburrato non sapeva che farsene. Una mattina non mi dava pace: allungava una zampa, mi tirava garbatamente i calzoncini, s'avviava verso la porta; poi tornava da me e nuovamente s'avviava, come se mi invitasse ad andare con lui. Andai. Miagolando sottovoce e ammiccando, volle che lo seguissi in giardino, sempre con una mimica che pareva un cristiano. Mi portò sopra un prato dove aveva esposto in bell'ordine, a ugual distanza l'uno dall'altro, i corpi di quattro enormi ratti di fogna.
Dai talponi di quella specie, grossi e feroci, i gatti si tengono alla larga più che possono: erano invece la caccia preferita di Ruggero, e quella volta che la preda della nottata era stata più abbondante del solito aveva voluto farsene bello con me. Ma davvero strabiliante era il modo in cui aveva accomodato le sue vittime, così bene allineate, con le lunghe code perfettamente parallele.
Visse a lungo: non meno di diciassette anni; e sarebbe certo campato di più, se da ultimo non gli fosse cresciuto sulla testa un grosso bubbone. Faceva pena a vederlo ridotto in quella maniera. Lo ammazzarono per pietà, una volta che ero sotto le armi o all'università, o non so dove.
Negli ultimi tempi, Ruggero s'era tirato su un successore: un grosso soriano, che però accanto a lui pareva un gattuccio come se ne vedono tanti. Cresciuto all'ombra di quel despota rubesto e attaccabrighe, era mansueto e pacifico: una pasta di gatto; e Pasta fu appunto il suo nome. Anche quando era in fuga, rincorso per qualche sua marachella, bastava gridargli dietro: «Pasta, arrenditi!» e quello subito si arrendeva, buttandosi a pancia all'aria.
Cominciò poi, molto più tardi, la dinastia siamese, estintasi con una gattina in morte della quale scrissi un elzeviro raccontando di lei cose incredibili e vere. Era una gatta letterata, una gatta bibliofila: fra l'altro, collaborò assiduamente con me alla Vita di Niccolò Machiavelli. Mentre la scrivevo, stava distesa sulle carte e sui libri: ogni tanto mi dava una zampatina alla penna facendomi fare un fregaccio o uno scarabocchio, e sempre poi mi accorgevo che in quel momento stavo scrivendo una cosa inutile, che andavo troppo per le lunghe, o che mi facevo riprendere dal vizio dell'erudizione. Se quel libro ha avuto tutte le edizioni e le traduzioni che ha avuto, è per molta parte merito suo.
Gatti, gatti, eterni dei. Nei paragoni e nei paralleli che mi vengono talvolta alla mente, considerando la mia indole, il mio stile, i miei modi e quelli dei gatti, m'accade d'invidiare la loro precisione, la loro pulizia ed eleganza, la loro morbidezza e leggerezza. A proposito di stile gattesco, credo che un bel po' sarebbe possibile trasferirne anche nello stile letterario; e magari ci riuscissi.
Una volta ne accennai qualcosa vagheggiando gli elzeviri del gattofilo Emilio Cecchi, «con quei tocchi simili alle zampatine di un gatto che gioca con un topo, e lui gioca invece con un'idea». Aggiungevo: «Dai gatti uno scrittore ha sempre da imparare parecchio: io, ahimè, sono stato soltanto un poco a scuola dalla mia gattina siamese. A lei piaceva tanto vedermi scrivere: almeno quanto a me scrivere. Ora sono qui che scrivo, e lei non c'è più».
Ma quanto è graziosa o almeno aggraziata, a paragone di queste canzonacce moderne, la canzoncina di Tremerello: Sognai, mi gera un gato/e ti me carezzevi. Come i gatti, sempre ho portato meco nella vita questo desiderio di carezze, che gattescamente m'invoglia qualche volta a graffiare. Con le parole, s'intende, perché altri artigli non ho.