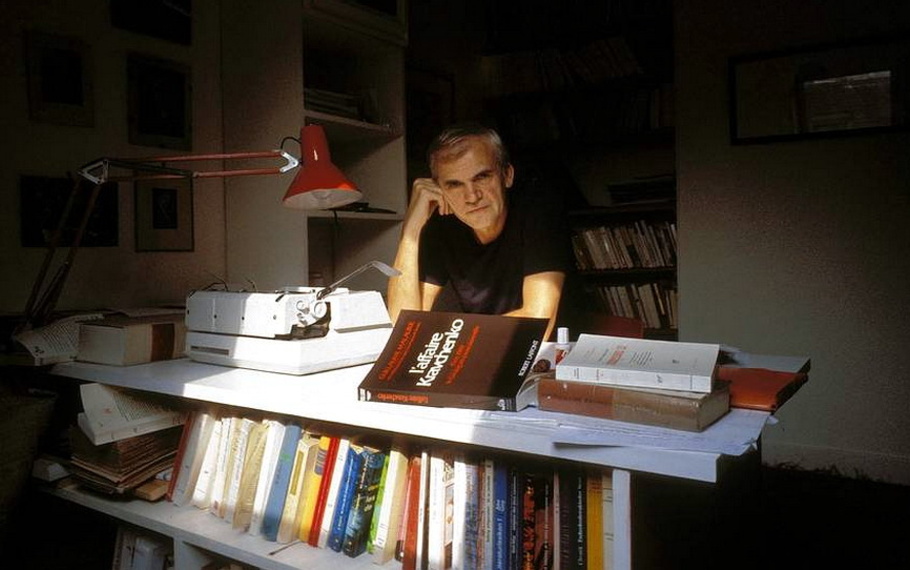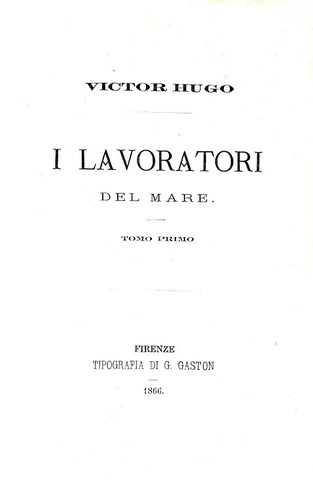Francesco Petrarca - Epistola ai posteri (Posteritati)

Brani scelti: FRANCESCO PETRARCA, Epistola ai posteri - Posteritati, metà XIV secolo.
Ai posteri salute. Avrai forse inteso dire alcuna cosa di me; avvegnachè è a dubitare che un nome, quale è il mio, piccolo ed oscuro sia mai per giungere a lontani luoghi ed a tempi avvenire. E chi sa se non ti prendesse vaghezza di conoscere qual uomo io mi sia stato, o come fossero accolte le opere mie, quelle principalmente di cui t'avrà parlato la fama, ovvero le altre che, di minor conto, appena ti saranno conosciute dal titolo? Però io tengo per fermo che in guisa affatto diversa la penseranno gli uomini de' fatti miei; giacchè ciascuno discorre non secondo ragione, ma secondo il proprio talento, e la lode ed il biasimo trasvanno ogni giusto confine. Certo anch'io mi fui uno del vostro gregge; mortale omicciattolo, non d'alta nè di bassa prosapia, ma, come Augusto disse di sè, d'antico casato. Natura mi diede indole non malvagia o invereconda, se le contagiose abitudini non l'avessero guasta. L'adolescenza ingannommi, la gioventù seco mi trascinò, mi fece più savio la vecchiaia, quando, maestra la esperienza, conobbi la verità di quel detto, che già altre volte letto avea: « non altro che vanità essere gli anni fioriti e il piacere. » Che anzi, più che altri, il facitore dell'età e de' tempi mi rese scorto di tanto; egli il quale permette talora che i tapini mortali, gonfii non più che di vento, qui e colà vadano errando, acciocchè tardi almeno si ravvedano dei commessi falli. Assai destra, avvegnachè non robusta, ebbi da giovane la persona; nè di singolar bellezza il sembiante, tale però che negli anni più verdi apparisse piacente; fresco il colorito tra il bianco e il bruno; vivaci gli occhi e la vista lungo tempo acutissima: se non che questa sul sessantesimo anno mi venne mancando; onde bisognommi, non senza repugnanza, ricorrere alle lenti. In ben disposte membra, che furono sempre sanissime, mi trovò la vecchiaia, dalla quale coll'usata schiera di malattie fui tolto in mezzo. Di buon lignaggio i genitori e d'origine fiorentina; mediocri le fortune e, a dir vero, volgenti al basso allorchè furono scacciati dalla patria.
Ond'io nacqui in Arezzo nell'esiglio, all'aurora del lunedì primo agosto 1304. Spregiai altamente le ricchezze; non perchè non le curassi, ma perchè mi veniano a fastidio le fatiche e le brighe che ne sono inseparabili compagne. Nè meno mi diedi cura di tesoreggiare, per aver modo ad imbandire splendide mense; dappoichè, contento ad un sobrio vitto ed a cibi comuni, vissi assai meglio che non i successori d'Apicio con tutta la squisitezza di loro vivande. Quelli che si chiamano conviti, e non altro sono che stravizzi, contrarii alla temperanza e al buon costume, ognora mi spiacquero, e stimai cosa non meno increscevole che vana sia l'invitare altri, sia l'esserne invitato, frattantochè il sedere a mensa cogli amici mi cagionava tanta dolcezza che nulla m'avessi di più caro; ma, solo, di mia volontà non avrei preso mai cibo. Al lusso poi non tanto fui avverso perchè sia mala cosa e nemica dell'umiltà, ma sì ancora per le malagevolezze che incontrano nel seguitarlo e l'interrompimento della quiete che apporta. Potentissimo fu l'amore ond'ebbi travaglio nella giovinezza, però unico ed onesto; più lunga guerra mi avrebbe dato, ove una morte dolorosa sì ma utile non avesse estinto il fuoco che già rattiepidiva. Ed oh foss'io stato libero d'ogni cupidigia di sensi! Ma mentirei, se il dicessi; affermerò solamente che, quantunque il fervore dell'età e della complessione mi trascinasse al piacere, sempre il mio pensiero ebbe a schifo cosiffatte turpezze. E non appena toccato il quarantesimo anno, mentre ancor mi sentiva vigoroso e robusto, di tal guisa m'uscì dall'animo ogni sconcio appetito che ne perdetti sin la memoria, come se non avessi mai guardato donna. Il che annovero tra le mie più singolari venture e ne ringrazio Iddio; il quale, in età ancor tanto fresca, volle liberarmi da un servaggio così vile ed odioso. Ma passo ad altre cose,
Per esempio altrui, non in me, provai che voglia dire superbia, e benchè uomo da poco, pur mi stimai da meno che il vero: così soventi volte a me nocqui, agli altri mai. Bramoso oltre ogni credere delle oneste amicizie, con tutta fede le coltivai; e perchè so di parlar vero, ad alta fronte mi glorio che, sebbene d'indole molto sdegnosa, dimenticai ben presto le ingiurie, ed i benefizii tenni sempre fissi nella memoria. E in ciò m'arrise la sorte che, non senza invidia, domesticamente usassi con principi e re, e nobili personaggi avessi ad amici; se non che toccommi la sciagura comune all'uomo che invecchia, di piangere assai spesso quelli che ama. I più ragguardevoli monarchi del mio tempo mi furono cortesi sì di onori e sì d'affetto; ed essi, non io, ne sapranno il perchè. Ed alcuno di loro conversava meco così familiarmente che la sua altezza non mi cagionasse noia, sibbene piacere. Da parecchi per altro de' miei più cari mi dilungai; tanto in me poteva l'amore di libertà! Onde avvenne che fuggissi a tutta mia possa da quanto non ne avesse il nome od a lei sembrasse contrario. Sortii ingegno piuttosto giudizioso che acuto, acconcio ad ogni onesta e salutar disciplina, ma inchinevole più che mai alla filosofia morale ed alla poesia; alla quale appresso volsi le spalle, tutto preso delle Lettere Sacre, in cui gustai una segreta dolcezza che un tempo avea posto in non cale: d'allora in poi non ho coltivate le poetiche discipline che a puro ristoro.
Ma ciò a cui mi diedi principalmente si fu lo studio delle antiche cose, perchè la presente età sempre m'increbbe: e se non fosse l'amore de' miei, io vorrei esser nato in qualsiasi altro tempo da questo in fuori; ond'è che, adoperandomi a dimenticare i viventi, a nulla più intesi che a vivere co' passati. Pertanto mi piacqui negli scrittori di storia, non senza però che il loro discordare non mi gravasse; e nel seguitarne le dubbiezze a quelli m'attenni che più avevano sembianza di vero o forniti erano di maggiore autorità. Chiara e potente, secondo alcuni, fu la mia eloquenza, ma, secondo me, fiacca ed oscura; e nell'intrattenermi cogl'intimi amici non mi curai punto di farne mostra, che anzi mi maraviglio come Cesare Augusto se ne desse tal pena. Quando però l'argomento, il luogo e gli uditori dimandarono altro, non tralasciai di porre alquanto di studio nell'esser facondo; e del come vi riuscissi, giudichino gli altri che m'ascoltarono. Nè di questo avrei fatto gran conto, purchè buoni fossero stati i miei fatti; che ventosa gloria è il cercar fama dalla splendidezza delle parole. Di questa guisa, siccome volle la fortuna o la mia volontà, mi corse diviso il tempo. Il primo anno di vita, nè tutto intero, lo passai in Arezzo, ove era nato; i sei appresso, quando mia madre fu richiamata dal bando, nella villetta paterna di Ancisa, non più che quattordici miglia discosta da Firenze; l'ottavo a Pisa; il nono e i seguenti nella città d'Avignone, posta nella Gallia transalpina, alla sinistra sponda del Rodano, dove la chiesa di Cristo dimora da lungo tempo in esiglio: e quantunque, pochi anni sono, Urbano V facesse mostra di riporla nell'antica sede, il suo pensiero tornò, come è noto, affatto vano; e, ciò che più m'attrista, mentr' egli ancora viveva, quasi che si fosse pentito dell'opera buona. E s'ei non avesse così presto lasciato il mondo, non gli sarebbe rimasto ignoto come io la pensassi del suo ritorno. Ma quando io stava per istringer la penna, finì infelicemente i suoi giorni, cui avrebbe potuto chiudere gloriosi dinanzi l'ara di Pietro e in propria casa. Perchè, o quei che gli successero se ne rimanevano a Roma, ed a lui durava la gloria dell'opera pia; o se ne dipartivano, e di lume tanto più vivo si sarebbe adornata la sua virtù quanto maggiore sarebbe paruta la colpa altrui.
Ma troppo lunghi e fuor di proposito suonerebbero adesso i miei lamenti. Ivi adunque, sulle sponde di quel fiume, ove può moltissimo il vento, passai sotto i miei genitori l'infanzia, e appresso, col giogo al collo delle mie vanità, tutta la giovinezza; non però così che non cercassi sovente altri paesi. Poichè in Carpentrasso, piccola città all'oriente d'Avignone e non molto da lei lontana, ebbi stanza quattro anni interi; due de' quali spesi in apprendere alcun poco di grammatica, di dialettica e di retorica, per quanto l'età e quelle scuole lo comportavano; e qual capitale di scienza io v'acquistassi, potrai di per te farne stima, o lettore carissimo. E per altri quattro anni dimorai in Mompellieri, a studiarvi la legge; quindi in Bologna, nella quale indugiatomi un triennio, appresi tutto il corpo del gius civile, dando di me, come dissero, giovane ancora, grande speranza, se avessi durato nell'intrapreso cammino. Ma io, tosto che fui signor di me stesso, volsi le spalle alle leggi: nè già perchè mi spiacesse la loro autorità, che fuor di dubbio è grande e piena di romana antichità, che tanto ammiro; ma sì perchè gli uomini iniquamente ne abusano. Onde m'increbbe addottrinarmi in ciò di cui mal voleva inonestamente valermi; e secondo coscienza mi pareva impossibile il farlo, perchè allora si sarebbe ascritta a dabbenaggine la mia purezza. Contava l'anno ventiduesimo quando me ne tornai in patria; tal chiamo Avignone, ove io avea dai primi anni menata mia vita, essendo vero che la consuetudine acquista forza di natura. E fu appunto colà che, cominciato a salire in fama, la mia amicizia fu cercata da' grandi. E come questo avvenisse, mal saprei dirlo al presente e non posso non restarne maravigliato; non così allora, che per giovanil leggerezza me ne credeva degnissimo. E sopratutto mi volle far sua la illustre e generosa famiglia dei Colonnesi, che di quei tempi frequentavano, anzi crescevano decoro alla curia romana. I quali oltre ogni mio merito mi onorarono, e principalmente il chiarissimo ed incomparabile uomo Iacopo Colonna, vescovo di Lombez, a cui somigliante non vidi e non vedrò forse nessuno. Egli, conducendomi seco nella Guascogna presso i colli Pirenei, mi porse modo, sì per la sua come per l'altrui gentilezza, a passare una state quasi celeste; cosicchè io non rammento quella stagione senza sospiri. Di là tornato, me ne stetti molti anni col fratel suo Giovanni Colonna cardinale, che trattandomi non da signore, ma da padre e amorosissimo fratello, più nella mia casa che nella sua mi parve abitare.
A quel tempo il giovanil desiderio mi trasse a visitare le Gallie e la Germania; e benchè, ad ottenere libera l'andata, fingessi gravi cagioni, altre in verità non ne avea che l'amor dello studio e la smania di cose nuove. Mossi dapprima a Parigi, ove opportunità d'investigare quel che di vero o di falso di lei diceva la fama. M'avviai appresso alla volta di Roma, cui sin dall'infanzia mi struggea di vedere; e trovatovi Stefano, magnanimo ceppo della casa colonnese ed uguale a qualsivoglia altro degli antichi, così me gli affezionai e per tal modo ne fui ricambiato d'amore che egli tra me ed i suoi figli non ponesse divario. E quell'uomo eccellente durò senza mutamento ad amarmi sino alla fine; nè in me venne meno o ne cesserà se non colla vita la ricordanza. Rivedute l'antiche mie sedi, cercando un luogo a che ripararmi come a porto, mi scontrai in una valle assai angusta, ma solitaria ed amena, che chiamano Chiusa, quindici miglia da Avignone, donde scaturisce il Sorga, re di tutte le fonti. Innamorato della bellezza del sito, mi vi trasferii in compagnia de' miei libri. Lungo sarebbe il raccontare tuttociò che vi feci nel corso di molti anni; ricorderò solamente che ivi o scrissi o principiai o imaginai quante opere mi uscirono della penna; le quali tante furono che io ne sono insino al giorno d'oggi stanco, anzi rifinito. Perchè, avendomi la natura dotato di tempra più operativa che robusta, mi convenne lasciar da parte assai cose, le quali se a gran fatica io giungeva a concepire, a condurle poi non mi bastavano le forze. E qui l'aspetto medesimo de' luoghi mi suggerì di comporre la Bucolica e i due libri Della vita solitaria, che intitolai a quel Filippo che, sempre grande, era allora vescovo della piccola Cavagliene, e adesso, fatto cardinale, occupa l'illustre seggio sabinense, unico che mi sopraviva di tanti amici; ed egli non episcopalmente, come Ambrogio Agostino, ma fraternamente mi amò e mi ama. Frattanto che traeva libera vita tra quei monti, un venerdì santo mi cadde in pensiero di scrivere un poema eroico che celebrasse quel primo Scipione Africano il cui nome fin da giovinetto m'era stato carissimo. Il quale, quantunque io mi vi accingessi con tutto l'ingegno, dovetti di corto abbandonare, a cagione di molte cure che mi sopravennero: però, dal suggello, lo intitolai dell'Africa, poema che, non so se per sua o mia fortuna, fu lodato da molti anche prima d'essere pubblicato.
Me ne dimorava tuttora nella mia solitudine, quand'ecco, e sembra incredibil cosa, nel giorno stesso giungermi lettere dal senato romano e dal cancelliere dell'università di Parigi che m'invitavano a ricevere la corona del poetico alloro. Ed io, inorgoglito di cotanto onore, e tenuto conto più delle altrui testimonianze che del valor mio, me ne reputai degno perchè uomini di tanta autorità mel conferivano. Siccome poi non sapeva a chi concedere la preferenza, mi volsi per consiglio al sovranominato Giovanni Colonna e gliene mossi inchiesta per lettera. Ed egli mi abitava così vicino che, scrivendo la sera, io poteva riceverne la risposta innanzi la terza del domani. Pertanto, attenendomi a quanto egli mi disse, prescelsi l'autorità del romano senato; e le due epistole che allora indirizzai all'amico sussistono qual documento dell'assenso che io porsi al suo parere. Andai dunque: ma sebbene, siccome giovane, mi mostrassi assai benevolo giudice delle mie cose, nell'atto di suggellare co' fatti la testimonianza ch'io rendeva a me stesso o quella di chi m'invitava, non potei non arrossire; se non che m'occorse al pensiero che, ove non ne fossi stimato meritevole, essi non m'avrebbero chiamato. Perciò, fermato di andarmene prima a Napoli presso quel sommo re e filosofo Roberto, non tanto pel regno che per la dottrina illustre, unico re dell'età nostra che fosse amico alle scienze ed alla virtù, lo domandai di ciò che meglio mi convenisse. Quali accoglienze ne ricevessi e di quanto affetto mi amasse è tal cosa che anche adesso mi cagiona maraviglia; e tu pure, o lettore, ne proveresti altrettanta, se là fossi stato presente. Non ebbe egli appena inteso il motivo della mia venuta che ne menò grandissima festa, pensando la mia giovanil confidenza e forse l'onore che gliene ridondava nell'aver eletto lui quale il solo giudice tra tutti i mortali. Che più? dopo un infinito conversare intorno a diversi argomenti, gli mostrai quell'Africa mia: della quale tanto si piacque che mi pregò, come di sommo favore, di volergliela intitolare; ned io seppi o poteva negarglielo.
Fissatomi poi un giorno all'effetto per cui io era venuto, dal mezzodì non mi lasciò sino a sera. E perchè al crescere delle materie corto era il tempo, protrasse l'esarne a due giorni seguenti: così, dopo che ebbe posto a prova il saper mio, nel terzo dì mi credette degno della laurea. Ed egli me la offeriva a Napoli, e non rifinì dal pregarmi perchè dalle sue mani l'accettassi; se non che l'amore di Roma vinse la gentil violenza di un tanto re. Il quale, tostochè mi vide immoto nel mio proposto, consegnommi sue lettere e spedì messi al romano senato in cui molto cortesemente apriva il suo giudizio intorno al mio sapere; regal giudizio ch'ebbe allora l'approvazione di molti e la mia principalmente: però, adesso che scrivo, nè a lui nè a me nè a quanti gli fecero plauso posso menarlo buono; l'amore che mi portava e la mia giovinezza ebbero sovra l'animo suo maggior potenza che il vero. Quindi, forte d'una tanto autorevole sentenza, tuttochè immeritevole, men' venni a Roma e, con sommo piacere di quanti intervennero a quella solennità, ignorante com'era, fui fregiato del poetico alloro; di che e in versi e in prosa v'ha alcune mie epistole. La laurea per altro, in cambio di apportarmi scienza, mi partorì molta invidia: ma questa storia altresì troppo più lunga che qui si convenga narrarla. Da Roma venuto a Parma, ospitai presso, que' signori di Correggio, che, discordi tra loro, la governavano con reggimento siffatto che quella città non n'ebbe mai a memoria d'uomini a sperimentarne l'uguale, nè, siccome auguro, alcun'altra sarà mai per averne di somigliante. Ed essi tanta amorevolezza e generosità mi usarono che io, conoscente de' ricevuti onori ed a mostrare che non li aveano indegnamente in me collocati, m'intrattenni alcun tempo con loro. Avvenne che un dì, nell'aggirarmi pei colli posti oltre l'Enza, sui confini di Reggio, m'inoltrassi nella selva che dicono Piana. Innamorato ad un tratto della bellezza di quella natura, mi posi nuovamente al lavoro dell'Africa e, ridestati gli spiriti che pareano assopiti, scrissi alcuni versi in quel dì e seguitamente parecchi altri ne' vegnenti; finchè, tornando a Parma ed appigionata una solinga e tranquilla casa, che dopo comperai ed è di mia ragione anche adesso, con tanto di ardenza proseguii nell'impreso poema che ne stupisco tuttora.
Avea già varcato il trentaquattresimo anno, quando feci ritorno al fonte di Sorga e alla mia solitudine oltre l'Alpi. Poscia ed in Parma e in Verona feci lunghe dimore; e dapertutto, la divina mercè, fui caramente accolto assai più che conoscessi di meritare. Come buon tempo trascorse, Iacopo da Carrara il giuniore, simile a cui non so se di quell'età v'ebbe mai alcun principe, anzi dico fermamente che no, risaputa per fama la mia celebrità, con lettere e messaggi sin al di là delle Alpi, quando colà stanziava, e in ogni altro luogo d'Italia cominciò a pregarmi, e per molti anni, affinchè quale amico me ne andassi a lui. Ond'io finalmente, sebbene non isperassi di crescere la misura della mia felicità, divisai di farlo contento e vedere così che significasse questo tanto vivo pressarmi d'un uomo potente e che io non conosceva. Venni adunque, benchè tardi, a Padova, e da quel principe di chiarissima ricordanza, non che fossi ricevuto cortesemente, ma sì come i beati s'accolgono in cielo; e tanta fu la gioia, l'inestimabile amore e la bontà sua ch'io, perchè non posso descriverla a parole, stimo meglio passarmene sotto silenzio. E questo ricorderò fra i molti suoi benefizii, che, sapendo siccome io da' primi anni era addetto alla vita ecclesiastica, affine di legarmi con nodi più stretti non solamente a sè ma anche alla sua città, volle che fossi eletto canonico di Padova. Conchiuderò dicendo che, se a lui bastava la vita, m'era questo il fine d'ogni viaggio e del mio tanto errare. Ma ahimè! che nulla v'ha quaggiù che sia durevole! perchè non appena alcun dolce si prova che tosto a guastarlo vi si mescola l'amaro. Non compiva ancora il secondo anno da che io viveva con lui, quando Iddio lo tolse al mondo e alla patria; dappoichè, se l'amore non m'inganna, nè io nè la patria nè il mondo eravamo degni di possederlo. E quantunque gli sia successo il figlio, sì per senno e sì per altre doti pregevole, il quale, seguendo il paterno esempio, sempre m'ebbe caro e lodato; io però, perduto lui, col quale anche per ragione d' età avea una maggior domestichezza, mai sapendo quietarmi, me ne ritornai nelle Gallie, non tanto per voglia di rivedere il veduto già mille volte quanto a sembianza de' malati, che col mutare di sito stimano di alleviare la noia.
Traduzione di Giulio Cesare Parolari